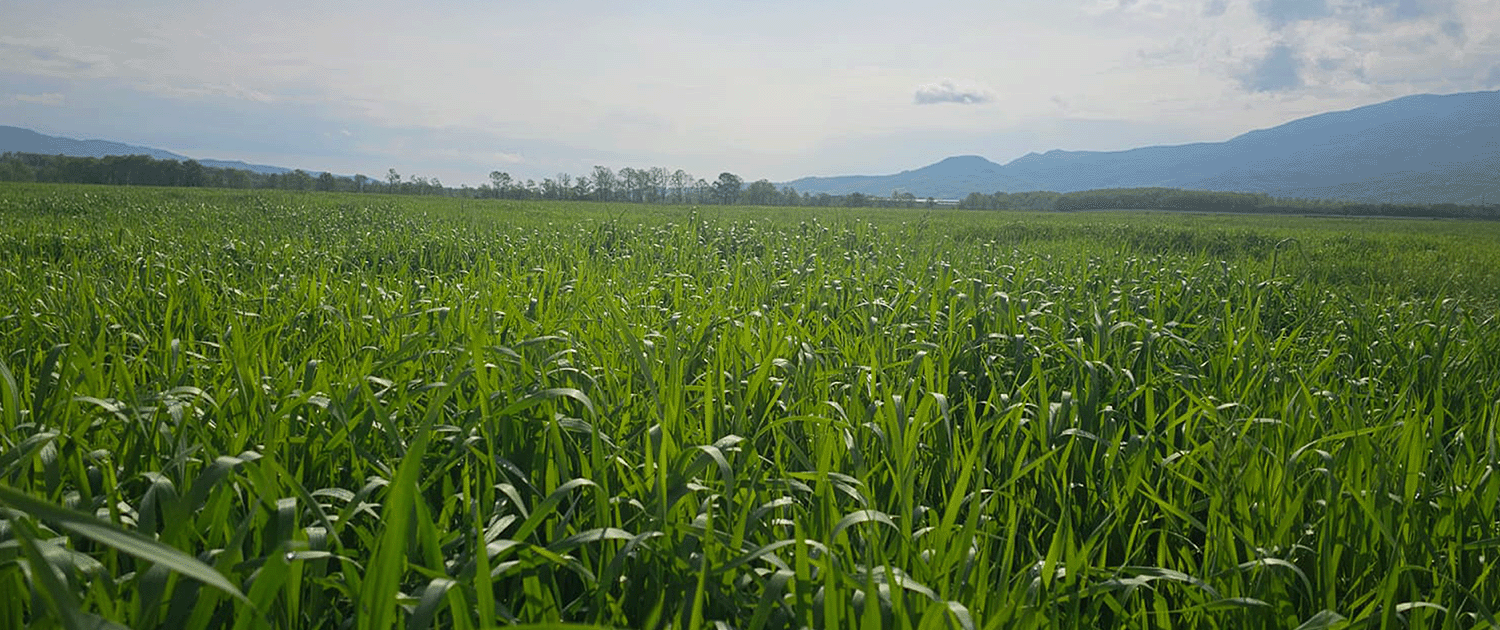La biodiversità agricola rappresenta uno degli elementi fondamentali per garantire la sostenibilità dei sistemi alimentari, la resilienza climatica e la sicurezza alimentare globale. In questo contesto, i grani antichi italiani assumono un ruolo chiave: non solo per il loro valore genetico, ma anche per la loro capacità di rispondere a esigenze ambientali, nutrizionali e culturali oggi sempre più pressanti.
Cosa sono i grani antichi
Con “grani antichi” si intendono varietà di frumento (sia duro che tenero) selezionate e coltivate in Italia prima della rivoluzione agricola del XX secolo, non modificate geneticamente né attraverso incroci intensivi o miglioramenti industriali. Tra questi troviamo:
- Timilia (Tumminia)
- Russello
- Maiorca
- Maiorca
Questi grani sono caratterizzati da altezza maggiore, maggiore rusticità, minore resa per ettaro, ma anche da un profilo nutrizionale e sensoriale distintivo.
Biodiversità e resilienza agroecologica
L’erosione genetica causata dalla monocoltura e dall’omogeneizzazione delle varietà moderne ha ridotto drasticamente la biodiversità agricola. Secondo la FAO, negli ultimi 100 anni è scomparso il 75% della diversità genetica delle colture (FAO, 2010). I grani antichi, al contrario, custodiscono tratti genetici unici che li rendono:
- Adatti a terreni marginali e poveri
- Resistenti a malattie e parassiti
- Meno dipendenti da fertilizzanti e pesticidi chimici
Uno studio del CREA (2023) ha mostrato che varietà siciliane come la Timilia e il Russello hanno una maggiore concentrazione proteica rispetto ai grani moderni, oltre a una miglior resilienza a stress ambientali (CREA, 2023, Int. J. Mol. Sci.).
Benefici nutrizionali e impatti sulla salute
Diversi studi (Dinu et al., 2018; Sofi et al., 2010) suggeriscono che i grani antichi contengono una maggiore quantità di polifenoli, antiossidanti e minerali rispetto alle varietà moderne. Inoltre, risultano avere un glutine meno tenace, aspetto che ne migliora la digeribilità, pur non rendendoli adatti ai celiaci.
L’Università di Firenze ha dimostrato che una dieta basata su pane ottenuto da grani antichi come il Verna può portare benefici al profilo lipidico e ridurre i marker infiammatori nel sangue (Sofi et al., 2010, Eur J Clin Nutr).
Implicazioni economiche e culturali
La riscoperta dei grani antichi è anche un fenomeno culturale e territoriale. In regioni come la Sicilia, la Toscana e la Basilicata, questi cereali sono diventati simboli di identità rurale e strumenti per il rilancio dell’agricoltura locale. Associazioni come Simenza – Cumpagnia Siciliana Sementi Contadine promuovono la conservazione in situ e lo scambio di sementi, in linea con la Convenzione sulla Diversità Biologica.
Iniziative come le Comunità del Cibo e della Biodiversità promosse dal Ministero dell’Agricoltura rafforzano questo legame tra produzione locale e tutela ambientale.
Sfide e prospettive future
Nonostante i vantaggi, la coltivazione dei grani antichi affronta ostacoli strutturali:
- Bassa produttività rispetto ai grani moderni
- Difficoltà di meccanizzazione
- Scarso riconoscimento nei disciplinari industriali
Tuttavia, il crescente interesse dei consumatori per prodotti salutari, biologici e locali offre nuove opportunità di mercato. È necessario un maggiore supporto istituzionale per ricerca, filiere corte e protezione legale delle sementi tradizionali.
I grani antichi italiani non rappresentano una semplice curiosità etnobotanica, ma un’autentica risorsa strategica per la biodiversità, la salute umana e lo sviluppo sostenibile dei territori rurali. La loro valorizzazione richiede sinergie tra ricerca scientifica, agricoltori custodi, enti pubblici e consumatori consapevoli.
Fonti
- CREA (2023), “Grani antichi siciliani più resilienti e proteici dei moderni” – International Journal of Molecular Sciences
- Sofi, F. et al. (2010), “Health effects of wheat varieties with different gluten content” – Eur J Clin Nutr
- Dinu, M. et al. (2018), “Whole grain consumption and health: A review of the literature” – Nutrients
- FAO (2010), The Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
- De Pascale, S. (2023), “Grani antichi: un patrimonio da tutelare” – Accademia dei Georgofili
- Università di Salerno (2022), “Grani antichi: il rilancio della biodiversità” – IRIS UNISA
Foto by www.freepik.com and www.pixabay.com